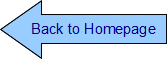
Cosa ci aspettiamo dalla poesia?
G.Berchiesi
Domanda a cui non è facile rispondere con una semplice frase. Possiamo dire che ci sono vari gradi di poesia? In una festa conviviale la poesia in genere è un insieme più o meno ordinato di luoghi comuni tenuti insieme dalla rima o dalla metrica. E questo indipendentemente dal livello sociale e intellettuale.
Ho avuto modo, ad esempio, di leggere alcune poesie celebrative del matrimonio tra il marchese Morici di Fermo e la contessa Teresa Conti di Tolentino (inizio 800): niente di più banale e scontato. Analogamente ho letto, riordinando il materiale del Comune di Petriolo, un libiricino di Poesie scritte dal marchese Ciccolini, che godeva fama di letterato e che suscitò un'onda di consensi entusiatsici di altri letterati. Un coacervo di amorini, ninfe e muse era la Poesia di Ciccolini. Quindi un'ammucchiata di luoghi comuni e scontati era etichettata come tessuto poetico. Ma con la sensibilità di oggi lo giudichiamo come gioco di società in cui solo la rima può essere legame con altre espressioni che la storia ci ha tramandato come poesie autentiche,
La poesia è una forma di comunicazione che diffonde il mondo interiore del poeta al lettore. Ogni forma di comunicazione però ha caratteristiche peculiari:
può essere Matematica, logico-filosofica, descrittiva, storica, Poetica.
Su tutte, l'espressione comunicativa di tipo poetico emerge per l'aspetto musicale. Eredi della poetica greca e latina, la metrica da un ritmo pulsante alle parole, molto prossimo al linguaggio musicale:
Ἀλλ'
ὅτε δὴ πόρον
ἷξον ἐϋῤῥεῖος
ποταμοῖο
Ξάνθου
δινήεντος, ὃν
ἀθάνατος τέκετο
Ζεύς,
ἔνθα διατμήξας
τοὺς μὲν πεδίον
δὲ δίωκε
πρὸς
πόλιν, ᾗ περ Ἀχαιοὶ
ἀτυζόμενοι
φοβέοντο
ἤματι
τῷ προτέρῳ, ὅτε
μαίνετο φαίδιμος
Ἕκτωρ·
(dal canto 21° dell'Iliade)
Inoltre, spesso ma non sempre, anche la rima, cioè l'assonanza tra parole finali di versi vicini, concorre a creare questa musicalità.
(Giosuè Carducci)
L'albero a cui tendevi
la pargoletta mano,
il verde melograno
Dà bei vermigli fiori
Nel muto orto solingo
Rinverdì tutto or ora,
E giugno lo ristora
Di luce e di calor.
Tu fior de la mia pianta
Percossa e inaridita,
Tu de l'inutil vita
Estremo unico fior,
Sei ne la terra fredda,
Sei ne la terra negra;
Né il sol piú ti rallegra
Né ti risveglia amor.
|
IL PASSERO SOLITARIO (G.Leopardi)
D'in
su la vetta della torre antica, |
Tutta vestita a festa La
gioventù del loco |
Leopardi ad esempio non usa la rima, ma forse è il più musicale dei poeti.
Ma a parte questi aspetti che possiamo definire “formali”, quale è il contenuto della poesia? Non c'è nella poesia un limite al soggetto: si può andare dal sentimento al pensiero Infatti non si deve credere che un pensiero sia più adatto ad un saggio che alla poesia. Basta spaziare dal Carducci a Pascoli, basta pensare all'albero a cui tendevi la pargoletta mano, ripensare a San Lorenzo io lo so perchè tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché si capisca che i sentimenti, le sofferenze giochino un ruolo fondamentale nell'espressione poetica, dopo che questi sentimenti hanno fatto un percorso di pulizia emotiva nella mente dell'autore. Quindi il dolore in questi poeti ha avuto un percorso nella mente, nel pensiero dell'artista per trovare una forma espressiva, che ha attenuato le punte dolorose più pungenti, trovando così un equilibrio e l'aspetto meno individualistico.
Se poi si pensa a Leopardi e al suo Infinito sembra quasi che sia un soggetto di natura filosofica, che nell'autore si è rivestito di una musicalità e di una visione fatalistica della vita, fino a diventare poesia.
L'Infinito
(G.Leopardi)
Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo; ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l'eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s'annega il pensier mio:
e il naufragar m'è dolce in questo mare.
Leggiamo cosa scrive Leopardi nello Zibaldone:
Dolor mio nel sentire a tarda notte seguente al giorno di qualche festa il canto notturno de' villani passeggeri. Infinità del passato che mi veniva in mente, ripensando ai Romani così caduti dopo tanto romore e ai tanti avvenimenti ora passati ch'io paragonava dolorosamente con quella profonda quiete e silenzio della notte, a farmi avveder del quale giovava il risalto di quella voce o canto villanesco.
Non sembra forse una prova in prosa del tessuto dell'Infinito?
Come pure, sempre nello Zibaldone leggiamo:
Il più solido piacere di questa vita è il piacere vano delle illusioni. Io considero le illusioni come una cosa in certo modo reale stante ch'elle sono ingredienti essenziali del sistema della natura umana, e date dalla natura a tutti quanti gli uomini, in maniera che non è lecito spregiarle come sogni di uno solo, ma propri veramente dell'uomo e voluti dalla natura, e senza cui la vita nostra sarebbe la più misera e barbara cosa. Onde sono necessari ed entrano sostanzialmente nel composto ed ordine delle cose.
Non è forse una prova di quello che poi entrerà come tessuto di A Silvia?
|
A Silvia (G.Leopardi)
Silvia,
rimembri ancora Sonavan le
quiete Io gli studi
leggiadri
|
Che pensieri
soavi, Tu pria che
l’erbe inaridisse il verno, Anche perìa
fra poco |
Quale è il fine della poesia? Sempre secondo Leopardi:
Grandissima parte dell'opere utili procurano il piacere mediatamente, mostrando cioè come ce lo possiamo procurare, la poesia immediatamente, cioè somministrandocelo. (Zibaldone)
La musicalità è un elemento essenziale nella comunicazione poetica. A parte la filosofia o la matematica (che solo un addetto a quel linguaggio può comunque sentire come musicale, a causa dell'armonia del costrutto logico) la poesia ha questo aspetto musicale, anche se in una certa dose è presente pure nella prosa
La prosa per essere veramente bella e conservare quella morbidezza e pastosità comporta anche fra le altre cose di nobiltà e dignità... che abbia sempre qualche cosa del poetico, non già qualche cosa particolare, ma una mezza tinta generale...(Zibaldone)
Basti pensare alla fine del romanzo I miserabili:
Era rovesciato all'indietro e la luce dei due candelieri l'illuminava; la sua faccia bianca guardava il cielo, mentr'egli lasciava che Cosette e Mario gli coprissero le mani di baci: era morto.
La notte era senza stelle e profondamente scura. Nell'ombra, certo, stava ritto qualche angelo immenso, colle ali spiegate, ad attendere l'anima. (V.Hugo, I miserabili)
Oppure
Addio/ monti sorgenti dall'acque- ed elevati al cielo/ cime inuguali/ note a chi è cresciuto tra voi/ e impresse nella sua mente/ non meno che l’aspetto de' suoi familiari/ torrenti- de' quali si distingue lo scroscio/ come il suono delle voci domestiche/ ville sparse e biancheggianti sul pendìo/ come branchi di pecore pascenti/ addio!/ Quanto è tristo il passo di chi/ cresciuto tra voi/ se ne allontana!// (A.Manzoni, I promessi sposi)
Inoltre è scontato che l'arte non è un mestiere e, come dice Leopardi,
“Facoltà ridotte ad arte isteriliscono” (Zibaldone)
E Leopardi intravede quattro cause:
Che nessuno pensa più ad accrescere una facoltà già stabilita ordinata composta e che si ha per perfetta
...quasi tutto il volgo di quelli che si applicano alla poesia non ardiscono di violare nessuna delle regole stabilite
più comune alle persone di senno e giudiziose e capaci ed anche esimie è il costume e l'abitudine dal quale non si sanno staccare
...quando anche un bravo poeta voglia effettivamente astrarre da ogni idea ricevuta da ogni forma da ogni consuetudine e si metta a immaginare una poesia tutta sua propria, senza nessun rispetto, difficilissimamente riesce ad essere veramente, anche senza avvedersene, senza volerlo, sdegnandosene ancora, ricadrebbe in quelle forme, in quegli usi come un riozzolo d'acqua che corre per luogo dov'è passata altr'acqua...
Io penso che la poesia sia uno stato dell'uomo e che ognuno di noi la possieda internamente. Occorre soltanto quella emozione, quel fatto, quella visione che attivi il processo per cui la comunicazione diventi poetica. In un'altra frase dello Zibaldone, Leopardi in un confronto tra la poetica di Ovidio e quella di Dante loda il poeta fiorentino per la sua sintesi, dote che rende i versi più densi di forza comunicativa. Non ho parlato di Dante perché la sua creazione va oltre il poetare intimistico ed è un affresco dell'umanità, delle sue colpe e della sua ascesa a Dio. Quanto possente sia la espressione sintetica di Dante lo possiamo capire da questi pochi versi che narrano la fine di Troia e della sua Regina.
|
Dante, Inferno XXX
E quando la fortuna volse in basso l'altezza de' Troian che tutto ardiva, sì che 'nsieme col regno il re fu casso, Ecuba trista, misera e cattiva, poscia che vide Polissena morta e del suo Polidoro in su la riva del mar si fu la dolorosa accorta, forsennata latrò sì come cane; tanto il dolor le fé la mente torta. |
In epoca romantica, Foscolo creò pure un poemetto in cui con un linguaggio alto ed aulico ed estremamente musicale estrae dall'umanità quanto di più nobile ed elevato sia stata in grado di esprimere.
Poesia, dal greco ποίησις , significa creazione, cioè l'Autore con la giusta scelta di parole e di metrica, crea un percorso quasi musicale percorrendo il quale scopriamo il suo mondo interiore. Poesia è comunicazione!